- Elementi di storia e di prospettiva:
Politiche europee di Istruzione e Formazione Professionale [1]
1. Le origini e gli sviluppi
Dai Trattati di Roma al Trattato di Amsterdam: le origini
L’educazione e la formazione professionale hanno da sempre rappresentato un settore di estremo interesse per la Comunità fin dalla nascita dell’Unione Europea, avvenuta in seguito al Trattato istitutivo di Maastricht del 1992.
La formazione professionale in Europa - art. 127 dei Trattati di Roma: la Comunità deve promuovere una politica di formazione professionale che deve supportare ed integrare quella degli Stati membri.
È possibile rintracciare un interesse della Comunità per la formazione professionale già a partire dal 1957, anno in cui i Capi di Stato e di Governo di Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Olanda diedero vita alla Comunità Economica Europea: l’art. 127 dei Trattati di Roma stabiliva che la Comunità dovesse promuovere una politica di formazione professionale a supporto ed integrazione di quella degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in merito a organizzazione e contenuto della formazione.
L’istruzione secondaria e superiore in Europa - art. 149 del Trattato di Amsterdam: la Comunità contribuisce allo sviluppo di un’educazione di qualità, incoraggiando a tal fine la cooperazione tra Stati membri. Per quanto riguarda l’istruzione superiore e l’educazione in generale, in base all’art. 149 del Trattato di Amsterdam del 1997, la Comunità contribuisce allo sviluppo di un’educazione di qualità, incoraggiando a tal fine la cooperazione tra Stati membri, attraverso un’ampia gamma di attività, come ad esempio la promozione della mobilità dei cittadini europei, la progettazione di piani di studio integrati, la formazione di networks europei, lo scambio di buone pratiche tra i principali soggetti che operano nel settore e l’insegnamento delle lingue parlate nell’Unione.
Che ruolo ha l’Unione Europea?
In base a quanto scritto, risulta chiaro il fatto che la formazione, l’educazione ed in particolare l’istruzione superiore, pur essendo fonte di interesse primario per l’Unione, non sono oggetto di una politica comune europea: tanto nel primo caso, quanto nel secondo la competenza primaria in materia spetta ai governi nazionali. Tuttavia, non sarebbe corretto affermare che il ruolo della Comunità sia limitato alla semplice armonizzazione delle decisioni prese a livello nazionale, oppure alla loro mera “europeizzazione”. Di fatto la Comunità, attraverso l’adozione di numerosi atti ufficiali e linee di finanziamento esclusivamente dedicate ai vari settori dell’educazione e della formazione in Europa, contribuisce a:
- armonizzare le politiche nazionali in materia (richieste di adeguamento a standard europei);
- promuovere strategie di co-ordinamento e co-operazione tra enti di formazione e istituti europei;
- promuovere la mobilità di cittadini europei;
- sviluppare e supportare networks europei attraverso lo scambio di buone pratiche tra i principali soggetti che operano nel settore;
- mettere a punto piani di azione integrati e promuovere strumenti finanziari per realizzarli.
Dal Libro bianco del 1993 alla nascita del concetto di Lifelong Learning: Il rafforzamento delle politiche di Istruzione e formazione in Europa
Il Libro Bianco sulla strategia a medio termine a favore della crescita, della competitività, dell’occupazione (noto anche come Libro Delors - 1993)3, propone una serie di orientamenti generali per la crescita e lo sviluppo che puntano su una economia aperta e competitiva. Sei sono gli obiettivi indicati. Uno di questi consiste nel puntare sull’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita, al fine di sviluppare l’attitudine ad apprendere, a comunicare, a lavorare in gruppo, nonché adeguare continuamente il know-how e la formazione dei cittadini lavoratori. Un obiettivo che passa soprattutto dalla creazione di un vero e proprio diritto alla formazione continua, tema che dal 1993 ad oggi sarebbe diventato chiave del dialogo a livello europeo ed intorno al quale, da lì a qualche anno, si sarebbe sviluppato il concetto di apprendimento permanente, vero fulcro delle politiche europee del settore.
In questo senso, il 1996 può essere considerato l’anno della svolta: oltre che essere l’anno di pubblicazione del Libro verde sull’innovazione, è anche l’anno europeo dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita. Il messaggio chiave è: “non bisogna mai smettere di formarsi”.
Il concetto di apprendimento permanente, lifelong learning o apprendimento lungo tutto l’arco della vita, avrebbe costituito uno dei pilastri attorno ai quali si sarebbe sviluppato a partire dal 2000 il processo di Lisbona, considerato a ragione il punto nodale per lo sviluppo delle politiche di istruzione e formazione in Europa, come si evince dal Trattato di Amsterdam del 1997 in cui si specificava che «[…] la Comunità gioca un ruolo fondamentale nel promuovere l’educazione in Europa: quello di collaborare con gli Stati membri al fine di sviluppare un’educazione di qualità e di promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita».
Per quanto riguarda gli sviluppi dei “sotto-sistemi” dell’Istruzione e Formazione Professionale, prima del 2000 in Europea ancora separati a livello di policy e attori chiave, in riferimento in particolare all’istruzione superiore in Europa, il 19 giugno 1999, i Ministri dei Paesi membri si riunirono per sottoscrivere un importante documento che prenderà il nome di Dichiarazione di Bologna, con lo scopo di armonizzare i sistemi di istruzione superiore in Europa.
Per realizzare un’Area Europea dell’Istruzione Superiore e la promozione del sistema europeo di istruzione superiore su scala mondiale, la Dichiarazione di Bologna ha previsto il raggiungimento di sei principali macro-obiettivi:
- l’adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità ed armonizzazione;
- l’adozione di un sistema di studi basato su due cicli fondamentali;
- il consolidamento del sistema dei crediti didattici basato sul sistema ECTS;
- la promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione;
- la promozione della cooperazione in Europa per la valutazione della qualità dell’educazione;
- la promozione di una dimensione europea dell’insegnamento (sviluppo dei piani di studio, cooperazione fra istituzioni universitarie, programmi di mobilità, piani di studio integrati, formazione e ricerca).
Quello che ha rappresentato La Dichiarazione di Bologna per l’Istruzione Superiore, in termini di promozione di una dimensione europea, lo è stato per la Formazione Professionale il Consiglio Europeo di Barcellona, tenutosi nel Marzo 2002 durante il semestre di Presidenza spagnola dell’UE: l’obiettivo ambizioso era quello di adottare misure concrete atte a rendere i sistemi educativi e formativi in Europa un punto di riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010, intraprendendo, a tal proposito, azioni che riguardassero il miglioramento del sistema delle qualifiche, della trasparenza e della cooperazione a livello europeo nel campo della formazione professionale.
Il principale merito del Consiglio Europeo di Barcellona sta nell’aver portato a livello politico un processo che era già iniziato nell’ottobre 2001 con l’incontro di Bruges dei Direttori Generali per la formazione professionali (DGVT). Quella che venne in seguito chiamata “iniziativa di Bruges” mirava a creare una visione condivisa su quali miglioramenti apportare alle politiche VET (Vocational Education and Training, corrispondente all’acronimo italiano IFP - Istruzione e Formazione Professionale) in Europa, al fine di realizzare appieno la strategia di Lisbona. Focalizzando l’attenzione sui principi della trasparenza e della mutua fiducia, i Direttori presero atto della necessità di realizzare un approccio volontario e dal basso (bottom-up) nella cooperazione in materia di IFP, decidendo, a tal fine, di lavorare a stretto contatto con le parti sociali.
2. La Realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente nei sistemi di Istruzione e Formazione professionale
Il Consiglio Europeo di Lisbona e la Dichiarazione di Copenaghen: l’istruzione e la formazione professionale al centro dell’interesse comunitario
Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo di Lisbona incaricava i Ministri dell’educazione degli Stati membri di: «[…] intraprendere una riflessione generale sugli obiettivi futuri concreti dei sistemi educativi, concentrandosi su priorità e problematiche comuni, pur nel rispetto delle diversità nazionali e di presentare a tal fine un rapporto al prossimo consiglio europeo del 2001».
Un impulso decisivo in tal senso arrivava dal Vertice europeo di Lisbona del marzo 2000. Il Consiglio europeo, constatando che l’Unione si trovava dinanzi a “una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza”, si dotò di un obiettivo strategico forte: entro il 2010 l’Unione sarebbe dovuta «[…] diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».
Il Consiglio ribadiva come tali cambiamenti richiedessero non solo “una trasformazione radicale dell’economia europea” ma anche “un programma ambizioso per modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d’istruzione”. Mai in precedenza il Consiglio europeo aveva riconosciuto con tanta forza il ruolo svolto dai sistemi d’istruzione e di formazione nella strategia economica e sociale e per il futuro dell’Unione. Successivamente, il Consiglio Europeo adottò a Copenaghen nel novembre 2002 una Risoluzione sulla «[…] promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale» (VET). Tale risoluzione invitava gli Stati membri e la Commissione a compiere tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi fissati dall’iniziativa di Bruges, plasmando strumenti e strutture idonee e coinvolgendo le parti sociali, i Paesi membri dell’Unione Europea ed i Paesi membri EEA-EFTA. Proprio in seguito alla Dichiarazione di Copenaghen, l’iniziativa di Bruges ed i suoi obiettivi divennero parte integrante di quello che venne chiamato il processo di Copenaghen. Il processo di Copenaghen diede inizio ad una strategia comune per aumentare le qualità dell’Istruzione e Formazione Professionale in Europa, individuando quattro principali priorità da sviluppare:
- Dimensione europea,
- Trasparenza,
- Riconoscimento di competenze e qualifiche,
- Qualità
Per la prima volta venivano presi in considerazione tutti i livelli dell’Istruzione e della formazione professionale, ponendo l’accento sulla necessità di assicurare collegamenti appropriati tra l’istruzione e la formazione iniziale e continua in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
La Strategia di Lisbona e l’inizio di un nuovo approccio
Gli obiettivi posti a Lisbona erano molto ambiziosi ed invitavano gli Stati membri a porre in atto una serie di riforme strutturali nei settori dell’occupazione, della coesione sociale, dell’innovazione e delle riforme economiche6. Per realizzare tali obiettivi, si richiedeva ai Capi di Stato e di Governo di adottare programmi di ammodernamento dello stato sociale e di trasformazione dei sistemi di educazione e formazione in Europa, attraverso l’adozione di una strategia integrata (denominata strategia di Lisbona) volta al raggiungimento di tre fondamentali obiettivi da raggiungere nella prospettiva del 2010: i sistemi d’istruzione e di formazione dovevano unire qualità, accesso e apertura al mondo. Al fine di assicurare il raggiungimento di tali obiettivi, i Ministri dell’Educazione degli Stati membri adottarono nel 2001 un rapporto “sugli obiettivi futuri dell’educazione e della formazione” ed un programma di lavoro decennale sugli obiettivi di Lisbona, il programma “Istruzione e Formazione 2010”:
- migliorare la qualità e l’efficacia di tali sistemi; in termini di qualità, il programma mirava a migliorare l’istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori, sviluppare le capacità per la società della conoscenza, garantire a tutti l’accesso alle TIC, incentivare le candidature a livello di studi scientifici e tecnici, e sfruttare al meglio le risorse;
- assicurare a tutti l’accesso ad essi; per quanto riguarda l’accesso, il programma incentivava un ambiente d’apprendimento aperto e più “attraente” e sosteneva la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale;
- aprire le porte dell’educazione e della formazione al mondo; in riferimento all’apertura al mondo dei sistemi d’istruzione e formazione, gli obiettivi erano: rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa e ricerca e società in generale; sviluppare lo spirito d’impresa; migliorare l’apprendimento delle lingue straniere; aumentare la mobilità e gli scambi; rafforzare la cooperazione a livello europeo.
Di fatto, gli elementi chiave nella definizione di strategie effettivamente coerenti e globali d’istruzione e di formazione permanente erano dati da un’interazione efficace tra tutti gli anelli della catena dell’apprendimento, cui si accompagnasse l’istituzione di un quadro di riferimento europeo per le qualifiche dell’istruzione superiore e della formazione professionale. Il Programma “Istruzione e formazione 2010” individuava a tal proposito tredici obiettivi specifici che ricoprivano i vari settori dell’educazione e della formazione (formale, non formale e informale), con lo scopo di realizzare un sistema di apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed il miglioramento dei sistemi educativi, fissando degli indicatori specifici per verificarne il raggiungimento da parte degli stati Membri entro il 2010:
- dimezzare i tassi di dispersione scolastica rispetto a quelli rilevati nel 2000, per arrivare ad una percentuale media europea intorno al 10%;
- aumentare i laureati in discipline matematiche, tecnologiche e scientifiche almeno del 15% e diminuire l’attuale disparità di genere;
- portare all’85% la popolazione ventiduenne al completamento dell’istruzione secondaria superiore;
- diminuire le scarse capacità di lettura dei quindicenni almeno del 20%;
- coinvolgere almeno il 12,5% della popolazione adulta nella partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto il corso della vita.
La strategia di Lisbona viene considerata il punto nodale nello sviluppo delle politiche di istruzione e formazione in Europa: è a partire da Lisbona che educazione e formazione professionale evolvono di pari passo e vengono entrambe ricondotte all’interno di una strategia volta ad assicurare forme strutturate di educazione continuativa (letteralmente "che dura per tutta la vita"). Non a caso, da Lisbona in poi, non si parlerà più di politiche europee di istruzione e di politiche di formazione professionale; si parlerà invece di politiche di IFP – Istruzione e Formazione Professionale (o VET – Vocational Education and Training), in ottica di Lifelong learning (apprendimento permanente appunto). Sviluppare un approccio lifelong all’IFP, cioè in ottica di apprendimento permanente, significa investire sulla persona, promuovere l’acquisizione di conoscenze di base e fornire a tutti le stesse opportunità di accesso ad un insegnamento di alta qualità. Il lifelong learning, è l’elemento principale della strategia di Lisbona, fondamentale, non solo per la competitività e lo sviluppo delle politiche di occupazione in Europa, ma anche per realizzare l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo umano dell’individuo. Promuovere l’apprendimento permanente significa appunto:
- creare ponti tra diversi sistemi e livelli di istruzione e formazione professionale, e tra gli attori che ne fanno parte;
- sviluppare meccanismi e quadri di riferimento in grado di aumentare la qualità, la comparabilità e la trasferibilità di competenze e qualifiche di cittadini europei a prescindere dall’ambiente di apprendimento (formale, non-formale e informale), dal sistema (istruzione o formazione professionale) o dal Paese in cui le hanno ottenute;
- investire sulla mobilità degli individui, aumentando l’accessibilità e l’apertura al mondo dei sistemi di IFP in Europa, soprattutto attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento aperti e dinamici.
A partire dal 2000, tutti i provvedimenti e le strategie che verranno adottate a livello europeo in materia di Istruzione e Formazione Professionale saranno sviluppati in un’ottica di apprendimento permanente e faranno riferimento agli obiettivi posti e agli strumenti sviluppati da Lisbona in poi.
Nuovi strumenti e quadri di riferimento
La strategia di Lisbona ha l’indubbio merito di aver posto l’Istruzione la Formazione Professionale al centro dell’interesse comunitario.
In particolare:
- per la prima volta si è parlato di approccio integrato alle Politiche di istruzione e formazione professionale, volto ad assicurare forme strutturate di educazione continuativa. Nasce con la strategia di Lisbona e con la dichiarazione di Copenaghen il concetto di apprendimento permanente;
- da Lisbona in poi si è assistito ad un aumento del numero di programmi e linee di finanziamento destinate alle politiche di educazione e formazione professionale: dal 2000 in poi la Commissione ha appositamente dedicato al raggiungimento degli obiettivi posti a Lisbona una serie di programmi e linee di finanziamento specifici che aprirono la strada ad una nuova generazione di programmi europei. Il Programma comunitario Erasmus+ viene promosso dalla Commissione proprio con lo scopo di realizzare gli obiettivi posti dalla Strategia di Lisbona in poi;
- da Lisbona si è assistito ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle politiche di educazione e formazione professionale (bilancio EC 2005). Se si esamina il bilancio del 2005 della Commissione Europea facendo particolare attenzione alle voci di spesa dedicate all’istruzione e alla cultura (Il Titolo XV del bilancio generale della Commissione è espressamente dedicato alle politiche di istruzione e cultura), si apprende che la Commissione europea ha stanziato fondi pari a più di un miliardo di euro, rispetto ai quasi 827 milioni messi a disposizione nel 2003. Di questi, quasi 242 milioni alla formazione professionale (nel 2003 tali fondi ammontavano a poco più di 203 milioni di euro), a testimonianza del maggiore impegno assunto dalle istituzioni europee in attuazione della strategia di Lisbona e dei vertici di Bologna, Bruges e Copenaghen. A riprova dell’enorme importanza comunitaria assunta dai nuovi programmi di educazione ed istruzione, basti dire che dei 242 milioni di euro stanziati nel 2005 per la formazione professionale, 205.366.880 sono stati destinati al solo Programma Leonardo da Vinci (nel 2003 la voce di spesa del programma indicava un impegno di 170 milioni di euro);
- a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, le Istituzioni europee, insieme ai Paesi membri, hanno individuato e sviluppato strumenti e quadri riferimento in grado di promuovere, nello spazio europeo, la libera circolazione dei cittadini, dei loro titoli e curricula, per fare dell’Europa "la società della conoscenza più dinamica e competitiva del mondo", spostando l’interesse comunitario verso i risultati dell’apprendimento e la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e formazione professionale; in altre parole, dagli input, cioè dalla durata, dai contenuti, dagli argomenti, l’attenzione si sposta sugli output dell’apprendimento, tra cui ciò che si sa o si fare, indipendentemente dal “dove” e dal “come” lo si è acquisito. Agli attori politici, agli esperti del settore e agli enti di Istruzione e Formazione Professionale in Europea veniva richiesto con rinnovato vigore di lavorare allo sviluppo di strumenti, misure e azioni concrete utili a “calare sul terreno” e a mettere in atto l’approccio integrato alle Politiche di istruzione e formazione professionale.
Di seguito i risultati principali a cui ha portato questo processo, gli strumenti ed i quadri di riferimento sviluppati.
- Le Competenze Chiave per l’apprendimento permanente. La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave, identificava 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente. La Raccomandazione invitava gli Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle politiche educative, strategie per assicurare a tutti competenze chiave di apprendimento permanente con l’obiettivo di: 1. identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società della conoscenza; 2. coadiuvare l’operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell’istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l’arco della loro vita; 3. fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiuntamente. Il quadro di riferimento ha delineato otto competenze chiave: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in: Scienza e tecnologia; Competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.
- Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Il 5 settembre 2006 la Commissione ha adottato una proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ o EQF): si trattava di uno strumento che aiutava gli Stati Membri (i datori di lavoro, le persone) a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell’Unione Europea. L’EQF, che rappresenta tuttora uno dei risultati concreti del programma “Istruzione e formazione 2010”, si articola in 8 livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende (i risultati dell’apprendimento), indipendentemente dal sistema in cui è stata acquisita la qualifica. Gli otto livelli coprono l’intera gamma delle qualifiche, da quelle ottenute al termine dell’istruzione e della formazione di base a quelle assegnate ai più alti livelli di istruzione e formazione accademica e professionale (livello 8). L’EQF permette di migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei sistemi di istruzione e formazione europei: da un approccio tradizionale che poneva l’enfasi sugli input dell’apprendimento (durata del percorso formativo o educativo, tipologia di percorso e istituzione) si sposta l’accento sui risultati dell’apprendimento, espressi in termine di unità di competenze. Il 23 aprile 2008 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno formalmente ratificato la Raccomandazione. Gli Stati membri prima hanno adottato su base volontaria l’EQF ed entro il 2010 sono riusciti a correlare i propri sistemi nazionali di qualifiche (NQF) con l’EQF. Ciò significa che dal 2012, tutte le nuove qualifiche recano un riferimento esplicito all’EQF facilitando, almeno su carta, l’identificazione delle conoscenze, abilità e competenze di ciascun aspirante ad una occupazione attraverso l’Europa.
- Europass. In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, le Istituzioni europee, insieme ai Paesi membri, hanno individuato strumenti in grado di promuovere, nello spazio europeo, la libera circolazione dei cittadini, dei loro titoli e curriculum, per fare dell’Europa "la società della conoscenza più dinamica e competitiva del mondo". Tra questi strumenti c’era Europass (Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004), un insieme di documenti aggregati in un Dossier e pensati con l’obiettivo di rendere più trasparenti e leggibili i titoli, le qualifiche e le competenze acquisite nell’ambito di contesti di apprendimento formali, non formali e informali. I documenti che al momento fanno parte del pacchetto Europass sono: Europass Curriculum Vitae e Europass Passaporto delle Lingue, utili per descrivere le proprie esperienze e competenze, sono fruibili in auto compilazione; supplemento al Diploma e Supplemento al Certificato, utili per tradurre in modo trasparente i contenuti e il valore di titoli e qualifiche; sono prodotti da scuole, università e agenzie formative); Europass-mobilità, utile in caso di esperienze di studio all’estero, è rilasciato dal Centro Nazionale Europass Italia.
Europass è in uso presso 32 Paesi e il suo successo è comprovato dalla prosecuzione della sua diffusione.
- L’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è uno strumento pensato per descrivere un programma di studi attribuendo dei crediti alle sue componenti. La definizione dei crediti nell’istruzione superiore può essere basata su diversi parametri, quali il carico di lavoro per studente, i risultati dell’apprendimento e le ore di contatto. L’ECTS è un sistema incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro richiesto a uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio, obiettivi preferibilmente espressi in termini di risultati dell’apprendimento e di competenze da acquisire. L’ECTS è stato introdotto nel 1989 nell’ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma Erasmus+. È l’unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. Inizialmente concepito per il trasferimento dei crediti e per riconoscimento di periodi di studio all’estero, negli ultimi anni l’ECTS si è evoluto in un sistema di accumulazione di crediti valido a livello nazionale ed europeo, realizzando uno degli obiettivi della Dichiarazione di Bologna del giugno 1999.
- L’ECVET. Il 2 maggio 2005 la Commissione Europea ha approvato un documento di lavoro relativo al “Sistema europeo di accumulazione e di trasferimento delle unità capitalizzabili per l’Istruzione e la Formazione professionale”, in vista della definizione di un sistema di trasferimento di crediti per l’educazione e la formazione professionale (ECVET). L’obiettivo principale è stato quello di creare un quadro europeo di riferimento volto a promuovere la mobilità dei singoli individui in formazione e la mobilità lungo tutto l’arco della vita. Inoltre, l’ECVET è stato pensato come uno strumento in grado di facilitare il trasferimento, la valutazione ed il riconoscimento dei risultati di apprendimento ottenuti da individui che operano in contesti educativo/formativi diversi e/o all’interno di differenti sistemi di qualificazione. Nel 2012 è stato creato un quadro comune che descrive le qualifiche in termini di unità di learning outcomes (risultati di apprendimento), prevedendo procedure specifiche per la loro valutazione, trasferimento, accumulazione, validazione e riconoscimento: ogni unità è associata ad un numero di punti ECVET, sviluppati sulla base di standard comuni (60 punti per un anno di corso VET standard full-time). L’ECVET esige ancora oggi sforzi di armonizzazione e ingenti investimenti, ma rappresenta già da anni la chiave per aumentare la mobilità intereuropea, internazionale e per costruire percorsi di apprendimento permanente in grado di facilitare la validazione ed il riconoscimento dei titoli acquisiti in diversi contesti.
- Il Quadro di riferimento europeo per la qualità nella VET (EQAVET ex EQARF). È il Sistema approvato nel giugno del 2009 con l’obiettivo di promuovere e monitorare i continui miglioramenti raggiunti nei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale in tema di qualità. Gli stati membri sono stati incoraggiati a sviluppare nel 2011 un approccio comune per i sistemi di qualità, consultandosi con tutti gli stakeholder (sempre nel 2011 stati creati dei punti di contatto nazionali per la qualità). L’EQAVET è un quadro di riferimento che offre suggerimenti metodologici ai responsabili delle politiche di IFP (i policy maker), utili a verificare se le misure necessarie per migliorare i sistemi nazionali di IFP sono state messe in atto. Il quadro è costituito da: un ciclo qualitativo diviso in 4 fasi (definizione e pianificazione degli obiettivi, realizzazione, valutazione e review); criteri qualitativi e indicatori descrittivi per ogni fase del ciclo; indicatori comuni per misurare e valutare obiettivi, metodologie, procedure e risultati formativi.
- Il sistema Europeo delle Micro-credenziali: Le Micro-credenziali rappresentano il più recente strumento proposto, ancora in fase di sviluppo, a livello europeo nel settore istruzione e formazione professionale, al fine di fornire a studenti e giovani europei, ed in particolare ai più vulnerabili, opportunità flessibili e inclusive di apprendimento. Le micro-credenziali intendono rappresentare uno strumento utile a certificare i risultati di esperienze di apprendimento a breve termine, ad esempio una breve formazione modulare o corso. Offrono un modo flessibile e mirato per aiutare le persone a
sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per il loro sviluppo personale
e professionale. In Europa e nel mondo si stanno sviluppando rapidamente forme
di opportunità di apprendimento più brevi rispetto alle qualifiche tradizionali che
richiedono strumenti di certificazione più flessibili, come appunto le micro-credenziali,
in risposta alla domanda di forme di istruzione e formazione lifelong incentrate sul
“learner” ed inclusive, indirizzate cioè a una gamma più ampia di discenti, compresi i
gruppi svantaggiati e vulnerabili: le micro-credenziali sono di proprietà del discente,
possono essere condivise e sono portatili. Possono essere indipendenti o combinate in
credenziali più grandi e riferite ad un settore o ad un’intera area di attività. Tuttavia,
senza standard comuni che ne garantiscano la qualità, la trasparenza, la comparabilità
transfrontaliera, il riconoscimento e la portabilità, le micro-credenziali non potranno
raggiungere il loro pieno potenziale.
Anche per tali motivi il 16 giugno 2022, il Consiglio ha adottato una Raccomandazione
su un approccio europeo alle micro-credenziali per l’apprendimento permanente
e l’occupabilità11. La raccomandazione mira a sostenere lo sviluppo, l’attuazione
e il riconoscimento delle micro-credenziali tra istituzioni, imprese, settori e confini. La
raccomandazione fornisce elementi costitutivi, tra cui una definizione, elementi standard
per la descrizione delle micro-credenziali12 e principi per la progettazione e l’emissione
di micro-credenziali. Le micro-credenziali potranno in futuro essere sviluppate,
utilizzate e confrontate in modo coerente tra gli Stati membri, gli stakeholder e gli enti
dell’ecosistema istruzione e formazione, incluse le aziende. La raccomandazione soster-
rà in questo senso lo sviluppo al 2024 e l’adozione di micro-credenziali trasparenti e di
alta qualità, attuando azioni congiunte in questo campo con il coinvolgimento di enti
di IFP e di attori del mercato per massimizzarne l’efficacia. Ciò consentirà a studenti,
giovani in formazione e lavoratori che vogliono riqualificarsi, di apprendere nuove
competenze in modo personalizzato e inclusivo. L’approccio europeo alle micro-credenziali,
in questo senso, è una componente chiave della visione della Commissione di
realizzare uno Spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.
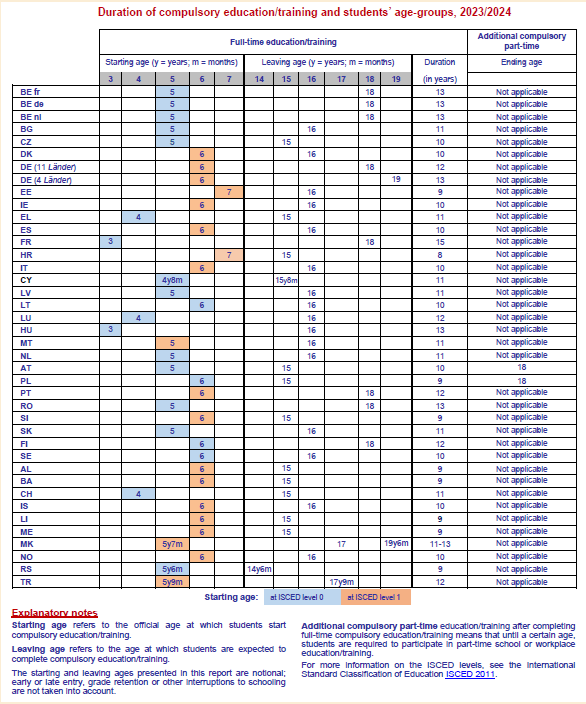
4. La libertà di scelta educativa in Europa
Perché amo la scuola
Dal discorso al mondo della scuola italiana, Piazza San Pietro 10 maggio 2014
[…] Sappiamo bene che ci sono problemi e cose che non vanno, lo sappiamo. Ma voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola. E dico «noi» perché io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da studente e da insegnante. E poi da Vescovo. Nella Diocesi di Buenos Aires incontravo spesso il mondo della scuola, e oggi vi ringrazio per aver preparato questo incontro. […]
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a sei anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo la scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io amo la scuola.
Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare - è questo il segreto, imparare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un prete: don Lorenzo Milani.
Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà - ho sentito le testimonianze dei vostri insegnanti; mi ha fatto piacere sentirli tanto aperti alla realtà - con la mente sempre aperta a imparare! Perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno «fiuto», e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, «incompiuto», che cercano un «di più», e così contagiano questo atteggiamento agli studenti. Questo è uno dei motivi perché io amo la scuola.
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. È un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. È un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi «socializziamo»: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: «Per educare un figlio ci vuole un villaggio». Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! Vi piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme: «Per educare un figlio ci vuole un villaggio!». Insieme! «Per educare un figlio ci vuole un villaggio!». E pensate a questo.
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. E nell’educazione è tanto importante quello che abbiamo sentito anche oggi: è sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca! Ricordatevelo! Questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme: «È sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Tutti insieme! È sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca!».
La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti «ingredienti». Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, ecc. Per esempio, se studio questa piazza, Piazza San Pietro, apprendo cose di architettura, di storia, di religione, anche di astronomia – l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno che questa piazza è anche una grande meridiana.
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori. E questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! Grazie ancora agli organizzatori di questa giornata e a tutti voi che siete venuti. E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!


